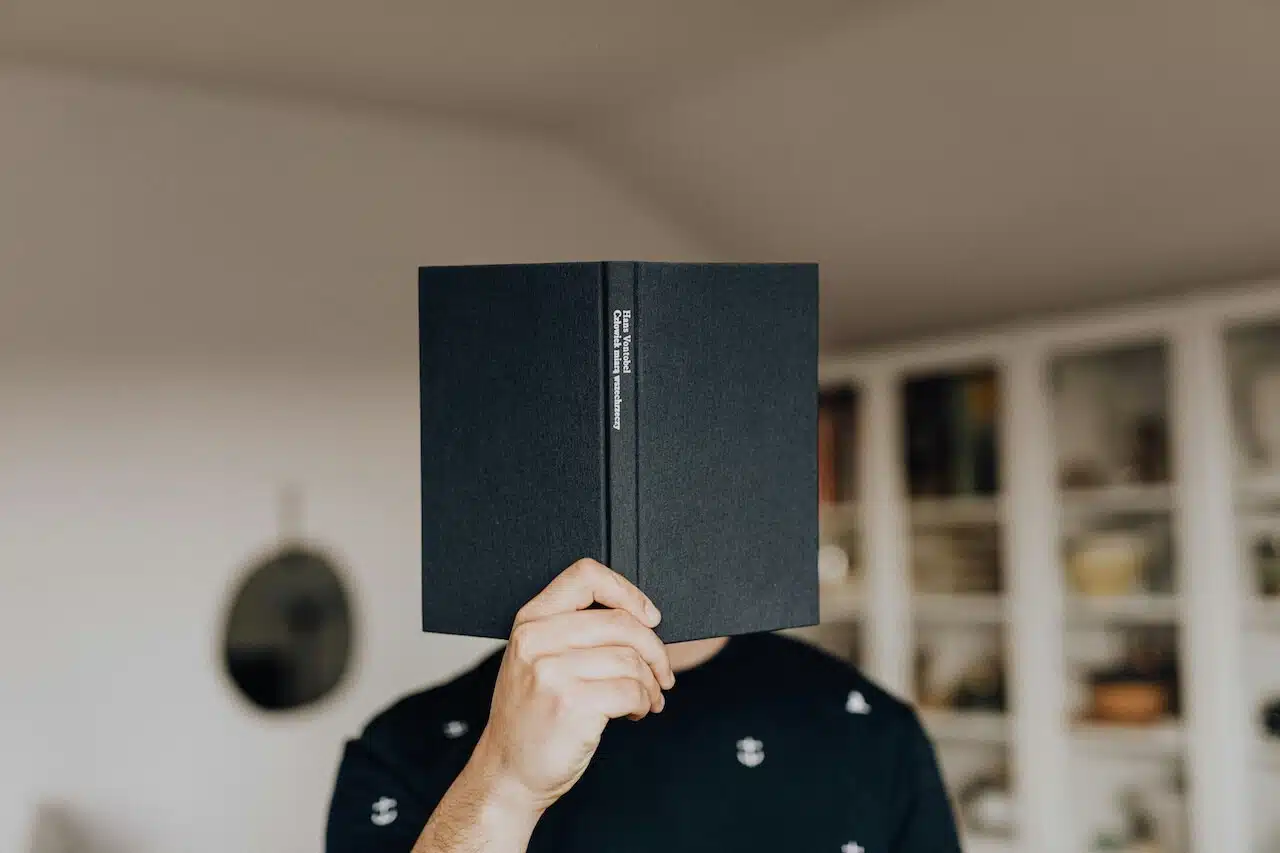
Nella società contemporanea, sempre più orientata alla performance e al controllo, non è raro imbattersi in pazienti che sviluppano un meccanismo di difesa particolarmente insidioso: l’intellettualizzazione. Si tratta di un processo inconscio che porta a costruire teorie sulle proprie emozioni, impedendo sostanzialmente di viverle. La sofferenza viene trasformata in un problema da analizzare, piuttosto che in un’esperienza da attraversare. Ma cosa significa realmente? E quali sono le conseguenze per il nostro benessere psicologico?
L’intellettualizzazione è un meccanismo di difesa psicologico attraverso il quale le emozioni vengono gestite esclusivamente sul piano cognitivo, evitando di sperimentarle nella loro pienezza. Chi utilizza questo schema tende a spiegare razionalmente i propri stati d’animo senza entrarci davvero in contatto. Frasi come “So che quello che mi è successo è stato traumatico, ma ormai è passato” o “Capisco che dovrei essere arrabbiato, ma non ha senso sprecare energie” sono tipiche di chi intellettualizza le proprie emozioni.
L’intellettualizzazione delle emozioni può nascere come risposta a un contesto familiare in cui i vissuti emotivi non erano accolti o venivano visti come segni di debolezza. Se da bambini ci è stato insegnato a “non fare drammi”, a “pensare con la testa e non con il cuore”, o se le nostre emozioni sono state minimizzate o ignorate, è possibile che da adulti abbiamo imparato a distaccarci emotivamente, trasformando le sensazioni in concetti astratti.
Inoltre, il contesto sociale sempre più orientato al controllo e alla dimensione prestazionale può sfavorire l’accettazione emotiva. Questo meccanismo si attiva soprattutto di fronte a situazioni di stress o dolore psichico. Pensare le emozioni, invece di sentirle, dà un senso di controllo: una protezione illusoria contro la sofferenza. Tuttavia, questa distanza emotiva può impedire la reale elaborazione emotiva, mantenendo il disagio sullo sfondo.
Evitare di sentire le emozioni non significa eliminarle. Al contrario, le emozioni represse trovano spesso altre vie per esprimersi: ansia, somatizzazioni, senso di vuoto, difficoltà nelle relazioni affettive. Si rischia di perdere il contatto con se stessi, vivendo in un costante stato di analisi senza mai permettersi di essere.
Chi ricorre all’intellettualizzazione in modo eccessivo spesso fatica a riconoscere i propri bisogni emotivi e può avere difficoltà a costruire relazioni autentiche, poiché queste richiedono vulnerabilità e apertura emotiva. Inoltre, quando certi meccanismi di difesa si radicano, possono compromettere anche la capacità di provare emozioni piacevoli, non solo quelle dolorose.
• Riconoscere il problema: il primo passo è accorgersi di questo schema. Ti capita di ragionare sulle tue emozioni più e più volte, senza venirne a capo?
• Dare spazio alle emozioni: provare a sentire, senza giudizio, ciò che emerge dentro di noi. A volte basta fermarsi, respirare e chiedersi: cosa sto provando in questo momento?
• Esprimere senza giustificare: le emozioni non devono sempre avere una spiegazione logica. Possiamo essere tristi, arrabbiati o delusi senza doverlo legittimare con una teoria.
• Coltivare la connessione corporea: attività come la meditazione, lo yoga o il movimento consapevole possono aiutare a rientrare in contatto con il proprio mondo emotivo.
• Chiedere aiuto professionale: se l’intellettualizzazione diventa un ostacolo alla salute mentale, un percorso terapeutico può aiutare a riconnettersi con il proprio sentire in modo più autentico.
Sentire le emozioni può essere spaventoso, ma è anche l’unico modo per elaborarle davvero. Pensarle soltanto non basta: il dolore non si dissolve con un ragionamento logico, ma con l’esperienza autentica dell’emozione. Solo quando ci permettiamo di sentire possiamo trasformare ciò che proviamo e liberarci da schemi difensivi che ci tengono bloccati.
Fonti:
Lingiardi, V., & Madeddu, F. (2023). I meccanismi di difesa. Teoria, valutazione, clinica.
González, Á. (2018). Non sono io: Imparando a comprenderci.